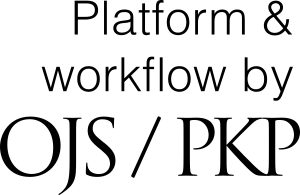«Griseldaonline», vol. 25 (2026) – Call for Paper: «Dati, metodi & interpretazioni»
2024-11-19
Dati, metodi & interpretazioni
Fino a qualche decennio fa, sembrava chiaro quali fossero le scuole critiche che concorrevano agli studi letterari. I Sette modi di fare critica, curati da Cecchi e da Ghidetti, e pubblicati nel 1983, enumeravano la critica storicistica, e insieme con lei quella stilistica, marxista, freudiana, sociologica, semiotica e militante. Oggi, però, queste scuole e i metodi che da esse procedono sembrano aver perso la loro carica propulsiva.
Leggi di più al riguardo di «Griseldaonline», vol. 25 (2026) – Call for Paper: «Dati, metodi & interpretazioni»